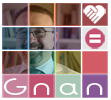Nonostante gli obiettivi di EUROPA 2020, in Italia si registra un calo del 30 % degli immatricolati, 40.000 laureati in meno negli ultimi dieci anni e 72.000 inscritti in meno nell’ultimo anno.
Nel nostro Paese la formazione superiore sta diventando sempre più uno strumento di ghettizzazione sociale. Secondo i dati dell’OCSE, in Italia, i ragazzi che provengono da un contesto socio-economico elevato hanno 10 volte più possibilità di accedere alla formazione terziaria rispetto ai loro coetanei che hanno genitori dotati di istruzione inferiore (in Europa tale livello si attesta al 4,5).
Affinché le Università Italiane riescano a garantire l’uguaglianza delle opportunità, devono diventare strumento di mobilità sociale e non promuovere l’esclusione sociale per via dell’insostenibilità dei costi.
Risulta fondamentale dare, quindi, un reale sostegno agli studenti garantendo borse di studio che rappresentino un reale contributo, ossia che tengano in considerazione i bisogni totali di vita di uno studente (troppi dei quali ignorati dal D.lgs. 68/2012) e che siano erogate in tempi adeguati. Occorre che sia lo Stato a coprire la totalità delle borse di studio, affinché i criteri di accesso siano uniformi su tutto il territorio e che questo contributo rappresenti l’unico strumento di welfare studentesco, in modo tale che i privati non si arricchiscano alle spalle degli studenti.
Quindi, per quanto riguarda il diritto allo studio, si richiede un rinnovato e sostanzioso investimento e una sostanziale riforma che definisca chiaramente il ruolo delle istituzioni coinvolte.
Affinché la didattica recuperi il ruolo di costruttore di coscienze civili (e non si occupi solamente di infondere il sapere tecnico) e gli studenti siano arricchiti da apprendimento attivo, occorre che il processo didattico sia rinnovato e che abbracci le moderne sperimentazioni. Tutto sarebbe possibile soltanto attraverso uno sblocco del turn-over che consenta il rinnovo degli insegnamenti e una nuova fluidità dei servizi. Tuttavia in Italia si assiste a una continua riduzione dei servizi a causa di continue riduzioni dei finanziamenti.
Per avere oggettivi criteri di valutazione e iniziare un costruttivo percorso di miglioramento, occorre un nuovo sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, in modo tale, che sia sempre assicurato il rispetto dei parametri minimi di qualità in termini di docenza e di strutture, e contemporaneamente siano garantite le finalità didattiche definite e controllate dalla comunità accademica.
Il sistema universitario italiano deve, quindi, innanzitutto abbattere sia le barriere formali di accesso alla formazione sia il sovraffollamento, assumendo nuovi docenti e investendo nell’edilizia universitaria. Tutto questo accompagnato da una serie di politiche di orientamento e supporto agli studenti.
Mentre l’Europa con la strategia di Lisbona ha fissato per i Paesi membri dell’UE un investimento del 3% del PIL in Ricerca e Sviluppo, l’Italia ancora investe per tale settore poco meno dell’1%.
L’effetto combinato delle leggi 133/2008 (manovra Tremonti), del 240/2010 (legge Gelmini), dei tagli alle risorse, del blocco del turn-over e dei differenti decreti attuativi, ha portato la diminuzione dell’offerta formativa, un aumento delle tasse per gli studenti, un aumento dei corsi a numero chiuso e una drastica riduzione dei precari della docenza e della ricerca.
Due sono stati i principali effetti della riforma Gelmini: la riduzione dei diritti di rappresentanza e l’aumento drammatico del precariato nella ricerca. La legge 240/2010 ha, infatti, costruito un sistema gerarchico dove il potere risiede nelle mani di organi nominati e non eletti, facendo sì che i precari non sono quasi mai rappresentati: su 75 università, 31 non riservano alcuna rappresentanza a questi, 42 la limitano ai consigli di dipartimento e solo 7 ai senati accademici. Mentre per i ricercatori a tempo determinato di tipo A e B, su 75 atenei, 5 non gli riservano alcuna rappresentanza e ben 23 la limitano al consiglio di dipartimento. Tale riforma ha poi portato all’eliminazione dei percorsi di stabilizzazione per quei docenti e ricercatori che da anni lavorano per gli atenei e non ha definito dei percorsi certi, addirittura ipotizzando 12 anni di precariato senza garanzie certe per il futuro.
Occorre, dunque, attuare immediatamente una soluzione che consenta al sistema universitario di risollevarsi e cambiare radicalmente sia il sistema di reclutamento sia le figure di pre-ruolo.
Occorre consentire agli assegnisti di ricerca e agli ex-ricercatori a tempo determinato della legge Moratti (230/2005), di poter concorrere per diventare ricercatore a tempo indeterminato di tipo B, ossia con la Tenure-track.
Occorre attuare un piano di reclutamento stazionario che permetta di sostituire i 10.000 docenti e ricercatori andati in pensione e non ancora sostituiti e, allo stesso tempo, ridonare dignità agli assegnisti e ai dottorandi, concedendogli l’indennità di disoccupazione e tutele sociali.
È necessaria una revisione del meccanismo di valutazione dell’abilitazione scientifica nazionale. Il nuovo progetto di cambiamento dell’ASN è, infatti, risultato assolutamente insufficiente e mancante e, inoltre, non ha modificato i poteri dell’ANVUR, che si sono dimostrati essere rovinosi per le università italiane.
Occorre riformare il dottorato di ricerca. Già nel 2012 l’Italia era l’ultimo Paese Europeo per numero di dottorandi e da qui al 2016 si stima che il numero subirà un’ulteriore ridimensionamento creando una difficile situazione soprattutto al sud. Per effetto del DM 45/2013 e della nota ministeriale 436/2014 si è avuto una diminuzione dei posti banditi annualmente del 25%.
Oltre a una trasformazione giuridica del dottorato occorre una valorizzazione di questo titolo al di fuori del mondo accademico, come avviene per tutto il resto d’Europa.
Occorre abolire gli assegni di ricerca insieme alla figura del ricercatore a tempo determinato di tipo a (Rtd-a) e creare una figura unica pre-ruolo sul modello retributivo, contributivo e di un inquadramento di Ricercatore a tempo determinato di tipo B (Rdt-b). Una soluzione potrebbe essere la creazione della figura di Junior Professor, con la tenure-track al termine dei 3 anni, in modo da garantire la partecipazione democratica di rappresentanza attiva e passiva negli organi delle Università dei ricercatori e dei pre-ruolo.
Occorre creare allo stesso tempo un ruolo unico per i docenti con la divisione in fasce, in modo tale che, dopo il dottorato di ricerca si possa accedere direttamente al concorso per Junior Professor. E’ necessario che tutto sia gestito e programmato dal MIUR, come le risorse finanziarie. Potrebbe essere anche introdotta una fascia intermedia di post-doc, non pagata con la borsa di studio, ma con un contratto di lavoro subordinato vincolato ad alcuni criteri, come il rapporto numerico tra post-doc e Junior Professor, la durata temporale dell’incarico e i fondi di finanziamento. Tutto questo dovrebbe essere programmato e gestito a livello centrale per evitare le solite discriminazioni.
Occorre anche il recupero di un processo di assunzioni ordinato e ciclico che copra non solo il 100% delle unità di personale cessato, ma che rappresenti anche un sostanziale investimento al personale che permetta di arrivare nel 2020 con 65.000 posti per i docenti universitari. È necessario anche un ampio reclutamento straordinario di nuove posizione tenured (6.000 all’anno per i prossimi 5 anni) utilizzando le risorse sia del pensionamento docente sia quelle provenienti dal recupero dei tagli finanziari effettuati.
Grazie a tutti questi cambiamenti, si potrebbe raggiungere un’età media di entrata in ruolo di 30-32 anni come per le altre università Europee.
Servono, quindi, investimenti e nuove politiche di riqualificazione sia per il ruolo di docente che per il percorso di accesso. Altrimenti assisteremo a un lento e inesorabile declino del sistema universitario italiano.
La costruzione di una via di uscita dalla crisi dell’università è un argomento complesso che da una parte è caratterizzato dall’ampia condivisione di alcuni aspetti più ovvi e dall’altra parte, invece, fa emergere i problemi che devono essere affrontati in un modo sistematico.
Uno degli aspetti importanti e ampiamente condivisi è rappresentato dalla carenza delle risorse finanziarie che servono per rilanciare il sistema universitario. Tuttavia, la restituzione di tutto ciò che è stato sottratto negli ultimi anni al sistema universitario non sarebbe sufficiente. Il sistema nel suo complesso è stato danneggiato dai modi inutili e dannosi di gestione della valutazione da parte dell’ANVUR.
Partiamo dai dati statistici: a differenza di ciò che si pensa, gli atenei italiani non sono troppi. Ciò è confermato dalle medie OCSE. Le università, specie quelle che si trovano nelle “periferie”, hanno un ruolo importantissimo sia in termini culturali sia in termini economici e sociali.
L’aumento del livello dei finanziamenti per l’FFO è molto importante, ma non è sufficiente. Bisogna studiare, quindi, con attenzione le strategie del loro utilizzo. Negli ultimi anni sono scomparse alcune importanti fonti di finanziamento nazionali per la ricerca, come ad esempio PRIM o SIR. Ai ricercatori è stato, in sostanza, richiesto di trovare le fonti di finanziamento con i propri mezzi. Inoltre, si dimostra sbagliata la pratica diffusa di premiare ciò che è già “eccellente”, perché i risultati della ricerca, come spesso accade, non sono prevedibili in anticipo.
Non basta, dunque, opporsi all’ANVUR. È importante sviluppare i percorsi di valutazione che devono partire “dal basso” per permettere agli atenei migliorarsi costantemente. Alla luce di un’elevata responsabilità sociale e un’elevata quantità degli studenti che non finiscono il loro percorso universitario ciò diventa ancor più rilevante.
Nel tema di finanziamenti, valutazione e articolazione territoriale dell’Università rimangono, comunque, alcune domande che non hanno una risposta. La prima riguarda la necessità di cambiare il sistema della valutazione, in altre parole vi è un bisogno di slegarla dalla premialità.
Un’altra domanda riguarda una fruibilità reale di diverse risorse per la ricerca: a parità di cifre erogate, la loro efficacia non è sempre uguale.
Alcuni aspetti della valutazione, come ad esempio la VQR, sono ben noti ai docenti universitari. Mentre altri aspetti (l’AVA, l’accreditamento periodico, la valutazione del “ciclo della Performance”) sono meno noti, ma avranno una ricaduta importante sugli atenei.
Non bisogna dimenticare della “responsabilità sociale” dell’Università. Le opinioni degli studenti sono obbligatoriamente raccolte, ma spesso e ben volentieri non sono analizzate e/o utilizzate.
Condividi su:Segui su: